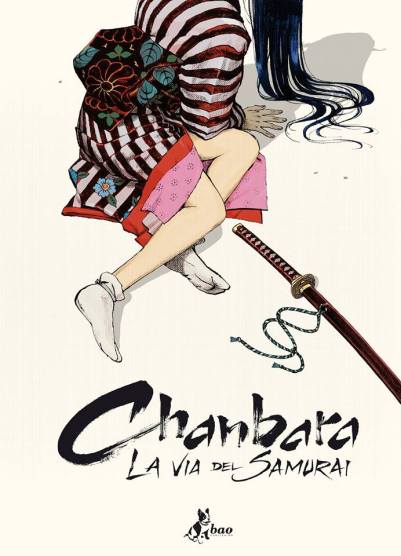Non basta una corda a fare un impiccato. È una frase che mi è sempre rimasta impressa, sin dalla prima volta che ho visto “Il buono, il brutto, il cattivo”, western culto di Sergio Leone del 1966. Se non sbaglio, a pronunciarla è Sentenza, il cattivo.
Non basta una corda a fare un impiccato. È una frase che mi è sempre rimasta impressa, sin dalla prima volta che ho visto “Il buono, il brutto, il cattivo”, western culto di Sergio Leone del 1966. Se non sbaglio, a pronunciarla è Sentenza, il cattivo.
Ma non importa chi la dice, ciò che importa è che questa frase mi è sempre suonata come un inno al non arrendersi mai.
Ed è questa la frase che mi è balenata in testa leggendo la storia che c’è dietro a “La notte del corvo” (Coconino Press- Fandango), un western moderno dell’autore Marco Galli, che qui si firma Apehands, ovvero mani di scimmia.
Torniamo indietro alla fine di marzo del 2016. Ricordo ancora quando la sorella di Marco diede la notizia attraverso la pagina social del fratello. Marco era stato colpito da un male oscuro, la sindrome di Guillain-Barrè, che lo tiene per sette mesi in bilico tra la vita e morte. Paralizzato, a parte gli occhi.
Poi il “risveglio” e la lunga riabilitazione. L’indebolimento dei muscoli gli nega per lungo tempo l’uso del pollice opponibile, ma Marco non si arrende; non rinuncia alla sua forma di espressione. Perché non basta una corda a fare un impiccato. E così Marco si inventa un nuovo modo di disegnare, lo fa nonostante la mano non gli obbedisca, lo fa in modo libero, furente, quasi anarchico; e se i disegni gli sembrano fatti da un’altra persona, lui inizia a firmarsi  con un altro nome, Apehands appunto.
con un altro nome, Apehands appunto.
La notte del corvo è il grande ritorno di Marco Galli, una ballata western potente e viscerale, un urlo di rabbia e di libertà. C’è un vecchio sceriffo candidato a sindaco, c’è un giovane giornalista che odia il selvaggio west, con la sua polvere e la puzza di merda di cavallo e vorrebbe scrivere di vizi, di soldi, di polo e di Henry James; “non di vaccari puzzolenti”. C’è la tedesca, che non rinuncia al piacere e segue soltanto i propri interessi. E poi c’è lui, El Grajo. «È un pistolero, un ammazza cristiani, uno dei più spietati, mi dice un tizio tra la folla accorsa per vedere il morto, se ci sarà. Mi dice anche che parla strano, è vestito tutto di nero e che gli manca qualche rotella…»
Dall’arrivo dell’uomo con la maschera da corvo tutto precipita in modo imprevedibile. E il sangue scorre a fiumi. Perché «Avete già capito che una faccenda violenta come questa non poteva finire in modo così scialbo. I conti si devono pagare quando si scomodano i demoni dell’inferno.»
Il pulp dilaga, le colt sparano, ma rimane lo spazio per una riflessione sulle disparità sociali e sui confini, sul diverso che fa paura. La nave carica di schiavi che naufraga sulle coste della ridente cittadina di Bajada e scatena il panico nella popolazione si rifà a un presente vicino, attualissimo. Una storia che fa pensare, una storia che è una ripartenza da una frontiera buia.
Un viaggio all’inferno e poi il ritorno.